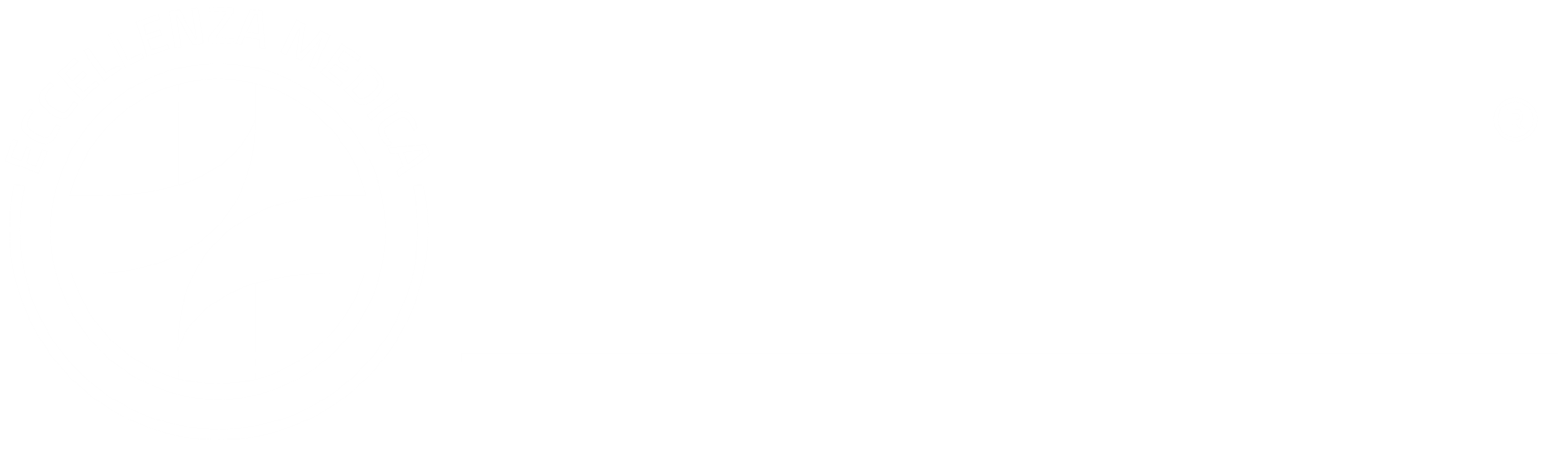La gestione dei pazienti fragili, in particolare degli anziani, rappresenta una sfida crescente per la medicina moderna, specialmente nel campo dell’endoscopia digestiva. Per approfondire questo tema di cruciale importanza, abbiamo intervistato il Dott. Orazio Labianca, Dirigente Medico di I livello di Endoscopia Digestiva diagnostica ed operativa presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, in servizio presso l’Ospedale Amico Gaetano Fucito di Mercato San Severino (Sa). Il Dott. Labianca ricopre inoltre un prestigioso Incarico di Alta Specializzazione (I.A.S.) in Endoscopia Oncologica.
Grazie alla sua approfondita esperienza clinica, il Dottore ci guida alla scoperta delle principali sfide, delle strategie più efficaci e delle prospettive future per garantire sicurezza, personalizzazione e protezione nell’approccio endoscopico ai pazienti più vulnerabili.

Dottor Labianca, in Italia cresce il numero di pazienti anziani con necessità di indagini endoscopiche. Quali sono oggi le principali sfide nel trattare pazienti fragili in ambito endoscopico, e come si può garantire sicurezza ed efficacia?
"Dai dati ISTAT sappiamo che nel 2024 la popolazione con oltre 65 anni è circa il 24,3% della popolazione residente in Italia (circa 59 milioni). Si prevede che entro il 2050, questa quota salirà al 34,6% su una popolazione totale stimata di circa 54,7 milioni. Pertanto, il numero di persone con oltre 65 anni passerà dagli attuali circa 14,5 milioni ai circa 19 milioni entro il 2050 e con esso il numero dei potenziali pazienti.
Nella moderna gastroenterologia, il trattamento dei pazienti fragili in endoscopia digestiva rappresenta una delle sfide più complesse ed importanti.
Il termine “paziente fragile” non ha una definizione unica ed universale e non è sinonimo solo di età avanzata ma in medicina viene utilizzato per indicare una persona che presenta una condizione di particolare vulnerabilità clinica, caratterizzata da una ridotta riserva funzionale fisica, psicologica o sociale, che rende il paziente più esposto e suscettibile a rischi di complicanze, eventi avversi, repentini peggioramenti o esiti negativi.
Spesso si tratta di pazienti con una limitata capacità di reagire ad eventi quali un’infezione, un trauma, un ricovero, con un significativo aumento del rischio di disabilità, perdita di autonomia o addirittura di morte.
Al fine di poter garantire sicurezza ed efficacia a questi pazienti così delicati, è necessario un approccio clinico multidisciplinare, con un’attenta valutazione prima dell’endoscopia, una personalizzazione di ogni fase del percorso (dalla scelta della preparazione, alla sedazione, alla tecnica) ed una comunicazione chiara e trasparente che ponga il paziente al centro di ogni decisione clinica.
In endoscopia digestiva, saper trattare un paziente fragile richiede un assoluto “cambio di paradigma”. Non si tratta più solo di eseguire manovre tecniche su un paziente, ma piuttosto di prendersi cura e saper gestire una persona complessa nel suo insieme".
Ha accennato un concetto che è il fulcro della mia seconda domanda: quando si parla di “fragilità”, spesso si pensa solo all’età anagrafica. Ma nella sua esperienza clinica, quali fattori rendono davvero un paziente “fragile” ai fini di un esame come la colonscopia?
"La definizione della “fragilità” di un paziente in vista di una colonscopia è un aspetto cruciale per garantire sicurezza ed appropriatezza dell’esame, ed è un concetto multidimensionale che va ben oltre la sola età anagrafica. Infatti, la fragilità non dipende solo dall’età, ma da una combinazione di fattori clinici, funzionali, sociali e psicologici.
Un paziente viene definito clinicamente “fragile” perché può presentare un maggior rischio di complicanze durante o dopo la procedura endoscopica, ha una probabilità più elevata di non essere in grado di tollerare la preparazione intestinale e la sedazione, e potrebbe trarre un minor beneficio dall'endoscopia stessa, qualora i rischi dovessero superare i potenziali vantaggi.
I principali fattori che rendono un paziente "fragile" per effettuare una colonscopia, sono dovuti alle condizioni cliniche generali ed alla presenza di comorbilità (cardiache, respiratorie, renali, epatiche, neurologiche, metaboliche) che necessitano di plurimi trattamenti farmacologici ed aumentano il rischio di complicanze ed eventi avversi.
Inoltre, vi sono fattori collegati all’età avanzata, oltre 80-85 anni, di pazienti che presentano una ridotta riserva funzionale d’organo, una ridotta autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane, un’instabilità posturale con gravi limitazioni nella mobilità autonoma, uno stato di disidratazione con squilibri elettrolitici, malnutrizione e sarcopenia, con una significativa perdita della massa e forza muscolare, che diminuiscono l’efficienza fisica e le capacità cognitive.
Inoltre, non sono da sottovalutare gli eventuali fattori sociali, come la difficoltà di gestire la preparazione intestinale o di recarsi in autonomia presso la struttura sanitaria, in assenza di un caregiver o un familiare che possa provvedere ad assistere il paziente prima, durante e dopo la colonscopia.
La fragilità rappresenta una condizione di vulnerabilità e debolezza che riduce la capacità di far fronte ad uno stress acuto come la preparazione intestinale e la sedazione cosciente della colonscopia. La decisione di procedere deve essere sempre personalizzata e condivisa con il paziente, i suoi familiari ed i medici che ne hanno in carico lo stato di salute, ben sapendo che, in alcuni casi, si può optare per esami meno invasivi come la colonscopia virtuale".
Negli ultimi anni si è evoluto l’approccio alla preparazione intestinale nei pazienti anziani. Quali strategie vengono adottate per ridurre il rischio di complicanze e migliorare la tollerabilità della procedura?
"La colonscopia nei pazienti anziani over 65 anni, ma con particolare attenzione a quelli con età superiore ad 80-85 anni, richiede un approccio estremamente ponderato, prudente e personalizzato, a causa della loro maggiore fragilità. L'obiettivo non deve essere il successo della procedura endoscopica, ma la sicurezza globale del paziente.
Qualora fosse necessario, si ricorre a schemi di preparazione intestinale personalizzati, che preferiscano le cosìddette preparazioni a basso volume (2 litri) o a dose frazionata, per migliorare l'effettiva aderenza del paziente e ridurne il disagio.
In genere, si utilizzano le preparazioni a base di polietilenglicole (PEG) che sono sicure ed efficaci, con l’eventuale aggiunta di sostanze tensioattive come il simeticone, incoraggiando un’adeguata idratazione con l’assunzione di liquidi chiari.
È importante fornire istruzioni scritte semplici, chiare e comprensibili, con caratteri grandi, facilmente leggibili e corredate da illustrazioni, coinvolgendo un familiare o un caregiver per assistere il paziente durante la preparazione.
In sintesi, la chiave per una colonscopia sicura e tollerabile nell'anziano è un “approccio multidisciplinare e personalizzato” che coinvolga l’endoscopista, i vari specialisti ed il medico di base che possono richiedere la colonscopia, focalizzandosi sulla scrupolosa valutazione prima della procedura, l’utilizzo di una corretta tecnica endoscopica e l’attento monitoraggio clinico continuo dei parametri vitali (saturazione d'ossigeno, frequenza cardiaca, pressione arteriosa ed ECG) per tutto il tempo della sedazione e dopo la procedura".
La colonscopia resta uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce del tumore del colon-retto. È corretto pensare che l’età avanzata sia un limite alla prevenzione?
"È indubbio che la colonscopia rappresenti lo strumento chiave nella prevenzione e la diagnosi precoce delle neoplasie del colon-retto, poiché consente sia di individuare le lesioni precancerose, come i polipi, che di rimuoverle.
Per quanto riguarda l’età avanzata, bisogna considerare che non rappresenta di per sé una controindicazione assoluta, sebbene con l’aumentare dell’età possono aumentare i rischi legati alla procedura, alla sedazione ed alle comorbidità.
In Italia, i programmi organizzati di screening per il tumore del colon-retto, prevedono l’invito alla prevenzione tramite test di ricerca del sangue occulto nelle feci e la colonscopia, e sono rivolti ad una popolazione di uomini e donne di età compresa tra i 50 e 74 anni, ma questo non significa che dopo non si possa continuare a farlo individualmente.
Nei pazienti anziani, oltre l’età massima prevista per lo screening, la decisione di proseguire la prevenzione dipende dallo stato generale di salute e dall’aspettativa di vita, dalla storia anamnestica familiare e personale, e dalla significativa presenza di sintomi e segni sospetti quali rettorragia, cambiamenti dell’alvo ed anemia.
In tal caso, la colonscopia non è più un esame di screening, ma un vero e proprio esame diagnostico, che trova la sua assoluta indicazione a prescindere dall’età.
Ecco perché, l’età avanzata non rappresenta un limite assoluto alla prevenzione, ma richiede una valutazione caso per caso che possa bilanciare rischi e benefici, nel contesto della situazione clinica specifica".
Dottore, vorrei affrontare con lei una questione particolarmente delicata. Mi riferisco alla gestione dei pazienti in terapia anticoagulante. Come si affronta oggi il bilanciamento tra il rischio emorragico e il rischio trombotico in vista di un’endoscopia?
"Questo è un punto cruciale e frequente nella pratica clinica quotidiana degli endoscopisti. Molti pazienti fragili assumono farmaci anticoagulanti (warfarin, DOACs) per condizioni come la fibrillazione atriale, il posizionamento di stent coronarici o di valvole cardiache meccaniche. La sospensione di queste terapie per una procedura endoscopica aumenta il rischio di eventi tromboembolici (ictus, infarto, trombosi venosa profonda, embolia polmonare), mentre il loro mantenimento aumenta in modo significativo il rischio emorragico, specialmente nelle procedure interventistiche.
L'approccio strategico è basato su una valutazione individuale del paziente, considerando tre fattori interdipendenti: il rischio trombotico del paziente che assume la terapia anticoagulante, il rischio emorragico della procedura endoscopica che si deve eseguire ed il timing della sospensione e della ripresa della terapia anticoagulante.
Per affrontare il bilanciamento tra il rischio emorragico e il rischio trombotico in vista di un’endoscopia digestiva, occorre classificare il rischio emorragico dell’endoscopia per comprendere quanto sia "pericolosa" la procedura pianificata in termini di sanguinamento, e valutare il rischio trombotico del paziente, ovvero la necessità di assumere la terapia anticoagulante e quanto sia “pericoloso” sospenderla.
Il bilanciamento è un atto medico complesso che richiede un’ampia discussione tra l’endoscopista, il cardiologo, il neurologo ed il medico di medicina generale del paziente, una corretta valutazione individuale del rischio/beneficio, il rispetto e la conoscenza delle linee guida più aggiornate ed accreditate dalle società scientifiche, per farmaci specifici, adattandole al singolo caso, secondo opportuni criteri di sospensione e sostituzione".
Esistono linee guida o protocolli condivisi per la sospensione temporanea degli anticoagulanti prima di una procedura invasiva come la polipectomia? Quanto conta la collaborazione multidisciplinare in questi casi?
"Si tratta di una domanda che affronta una problematica comune e standardizzata. Infatti, nella letteratura scientifica, esistono linee guida sia nazionali che internazionali basate sull’evidenza, ampiamente accreditate e consolidate, specifiche e dettagliate su questo particolare argomento.
La polipectomia endoscopica è una comune procedura endoscopica a carattere invasivo, in cui i polipi vengono rimossi dal colon, e che comporta un rischio di sanguinamento.
Gli anticoagulanti sono una classe di farmaci che fluidificano il sangue per prevenire la formazione di coaguli, come il warfarin ed i DOAC.
La collaborazione multidisciplinare in un team di specialisti è essenziale per bilanciare rischi e benefici, attenendosi a precise e coordinate tempistiche, che garantiscano la massima sicurezza durante e dopo la polipectomia endoscopica.
La gestione strategica dipende dal bilanciamento tra vari fattori:
- Il rischio emorragico della procedura, poiché non tutte le polipectomie sono uguali. La rimozione di un piccolo polipo con un'ansa “a freddo” può essere considerata a basso rischio. La rimozione di un grande polipo sessile con mucosectomia (EMR) o dissezione sottomucosa (ESD) è sicuramente ad alto rischio. Tutte le linee guida stratificano le procedure in basso ed alto rischio di sanguinamento;
- Il rischio tromboembolico del paziente, ovvero per quale motivazione egli assume anticoagulanti e come stratificare il rischio di una eventuale sospensione e/o sostituzione;
- Il tipo di anticoagulante utilizzato, warfarin o DOAC.
Si tratta di una gestione strategica ed una decisione consapevole da parte del Gastroenterologo / Endoscopista, per il quale le linee guida rappresentano un quadro di riferimento con raccomandazioni specifiche, da personalizzare sui fattori individuali del paziente, considerando che è buona norma non interrompere mai la terapia anticoagulante senza esplicite e valutazioni cliniche.
Guardando al futuro, quali innovazioni - tecnologiche e/o organizzative - potrebbero migliorare ulteriormente l'accesso e la sicurezza delle procedure endoscopiche nei pazienti più vulnerabili?
"Guardare al futuro dell'endoscopia digestiva nei pazienti vulnerabili e fragili (anziani, pazienti con gravi comorbidità e plurime patologie, con disabilità motorie e/o cognitive) significa affrontare un tema innovativo di grande attualità, per garantire un migliore accesso alle cure, con procedure più facili e tollerabili, ed una maggior sicurezza, che riduca i rischi procedurali e anestesiologici.
L'obiettivo da perseguire sarà quello di trasformare una procedura potenzialmente rischiosa e stressante in un'esperienza il più possibile sicura, tollerabile e efficace per tutti.
In un prossimo futuro, non tanto lontano, tra le varie innovazioni che stanno ridisegnando questo ambito tecnologico, sarà disponibile l’utilizzo di una “Endoscopia Robotica e di Precisione”, una “Micro-Robotica soft” che utilizzi piccole sonde endoscopiche robotiche, sempre più flessibili e sottili, di piccolissimo calibro, capaci di navigare in modo semi-autonomo nel tubo digerente, progettate per ridurre il trauma ed il disagio, permettendo procedure sempre più precise e meno invasive.
Ciò ridurrebbe drasticamente il bisogno di sedazione profonda ed il rischio di perforazione.
Saranno disponibili “Sistemi di Tele-Endoscopia Robotizzata”, dove un endoscopista esperto, in un centro di riferimento, potrebbe guidare a distanza un braccio robotico in un ospedale periferico, assistendo un collega meno esperto. Ciò migliorerebbe l'accesso alle cure ed alle competenze d'eccellenza anche per i pazienti che non possono essere trasferiti.
I benefici derivanti dell’utilizzo dell’Intelligenza artificiale guideranno l’endoscopista verso le scelte diagnostiche e terapeutiche più efficaci e sicure, minimizzando i rischi, e consentendo un imaging avanzato che rivoluzionerà la diagnosi precoce, consentendo di identificare con maggiore accuratezza le lesioni precoci e personalizzandone il corretto trattamento.
Il futuro dell'endoscopia digestiva per i pazienti vulnerabili sarà caratterizzato da una medicina sempre più personalizzata e predittiva, con procedure sempre più sicure e tecnologicamente avanzate. Nei prossimi anni, l’accessibilità alle tecnologie avanzate sarà una realtà sempre più disponibile e diffusa.
L’innovazione determinata dalla tecnologia robotica e supportata dall’Intelligenza artificiale sarà inevitabile, ma il vero miglioramento sarà guidato da un “cambio organizzativo”, che metta il paziente fragile al centro di un percorso dedicato, progettato su misura per le sue esigenze, con un approccio che consideri non solo la malattia, ma la persona nella sua complessità, e dove la tecnologia sia uno strumento al servizio di un processo clinico più sicuro, efficiente e umano".